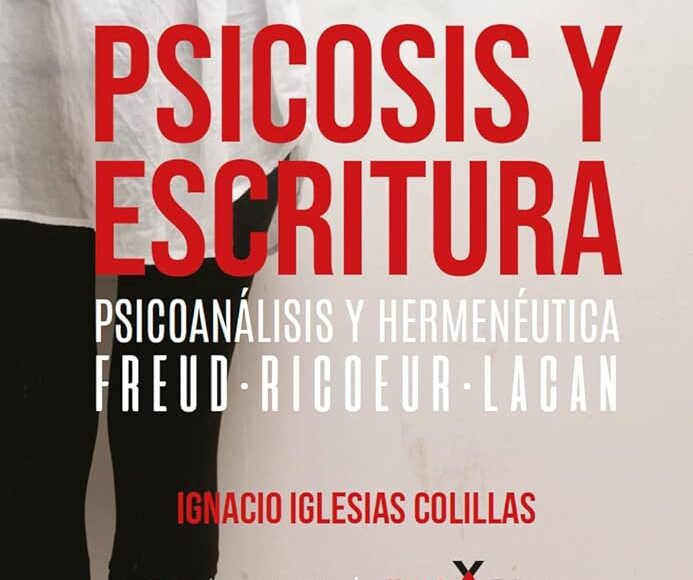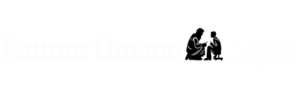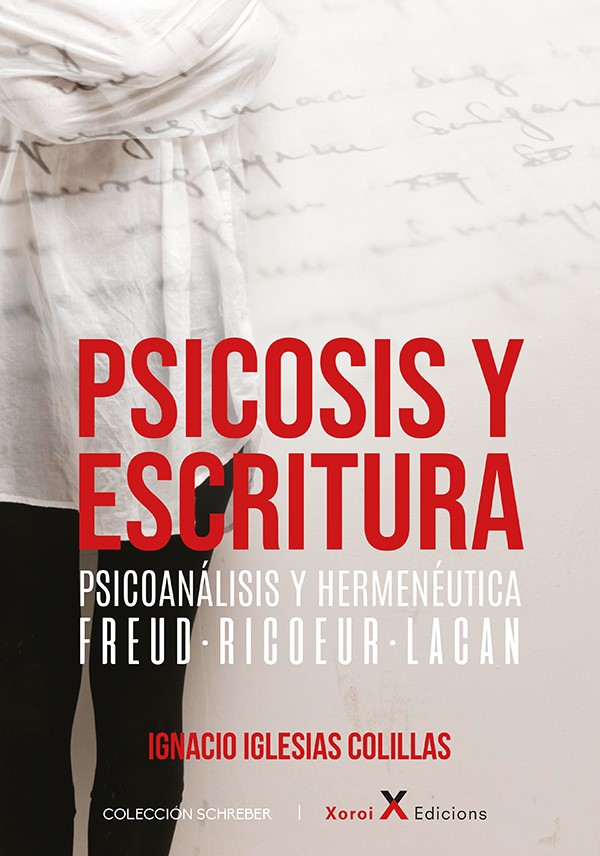
La scrittura dei folli: il caso Schreber
Metodologia e costruzione del caso Schreber, tra psicoanalisi ed ermeneutica
Dott. Ignacio Iglesias Colillas
Cliccare qui per leggere l’articolo completo in formato PDF scaricabile
Introduzione
Con questo mio lavoro vorrei condividere con voi alcuni risultati di una mia ricerca, che si è tradotta nel volume Psicosis y escritura (Xoroi Edicons, Barcelona, 2022) di cui Vinicio Busacchi e Giuseppe Martini hanno curato rispettivamente la prefazione e la postfazione.
Mi sono interessato alla psicosi per la mia tesi di dottorato e sin dall’inizio mi sono confrontato con la frequente evenienza che questi pazienti non solo scrivono a proposito delle loro sofferenze ma talvolta riescono a produrre anche testi poetici e letterari. Inoltre mi sono preso cura di molti pazienti che hanno condiviso con me i loro scritti durante le sedute di terapia ed ho coordinato durante alcuni anni un laboratorio di scrittura presso il Day Hospital dell’Ospedale per emergenze psichiatriche Torquato de Alvear a Buenos Aires. I confini tra lo spazio clinico e quello letterario a volte venivano reciprocamente travalicati dai pazienti e questo mi ha permesso di esplorare la relazione tra gli scritti e la sintomatologia delle differenti psicosi e naturalmente anche quella tra l’atto di scrivere e l’attenuazione di alcuni sintomi che da ciò poteva derivare, forse grazie alle successive discussioni in gruppo che favorivano la simbolizzazione di questi fenomeni. Altrettanto succede nell’ambito della mia pratica privata.
Di qui inevitabilmente la mia attenzione si è rivolta al famoso caso Schreber di Freud e pertanto alle Memorie di un malato di nervi, libro sul quale Freud basò la sua storia clinica, pur ricorrendo anche a diversi referti medici. Si può dire che questa storia sia la pietra angolare della teoria psicoanalitica della psicosi. E’ esattamente nel passaggio dalle Memorie alla costruzione della storia clinica di Freud che noi riveniamo una serie di problemi metodologici che fino ad oggi non sono stati ancora considerati esaustivamente. Mi riferisco al fatto che Freud aveva tematizzato il metodo delle libere associazioni per convalidare le sue interpretazioni; tuttavia questo metodo si rivela appropriato solo per il discorso orale caratteristico della seduta analitica, nel corso della quale possiamo contare sulla presenza del paziente per poter esplorare il significato del testo. Che cosa possiamo realmente sapere della soggettività dell’autore quando analizziamo un testo scritto o in che modo possiamo accedere all’intimo dell’essere, analizzando un testo? Nietzsche con la sua consueta acutezza affermava in Hecce Homo: «Una cosa sono io e un’altra cosa sono le mie opere». Torniamo però al nostro problema centrale. Secondo Freud «Poiché i paranoici non possono essere indotti forzatamente a superare le loro resistenze interne e comunque dicono solo quel che hanno voglia di dire, proprio per questa malattia è possibile supplire alla conoscenza personale del malato con una relazione scritta o con un caso clinico stampato» (1910, p.339 ed.it.).
Ma allora qual è il metodo dell’interpretazione psicoanalitica quando si tratta di testi scritti? Su questo Freud non riflesse mai esplicitamente ed è su questo piano che ho fatto ricorso, tra l’altro, alla ermeneutica testuale di Paul Ricoeur, che permette di superare le difficoltà epistemologiche e metodologiche qui considerate perché il testo è inteso come un oggetto di analisi specifico e con funzioni referenziali differenti a quelle del discorso orale. Soprattutto, i concetti dell’ermeneutica di Ricoeur permettono di decifrare e concettualizzare il singolare metodo di lettura freudiano realizzato a proposito delle Memorie.
Memorie di un malato di nervi
Prima di riferirci alla interpretazione che Freud propone nella sua storia clinica, soffermiamoci sullo scritto di Daniel Schreber datato 1900- 1902. Memorie di un malato di nervi è un libro particolare per una serie di motivi che desidero mettere in evidenza. In primo luogo, si tratta di una testimonianza autobiografica estremamente ricca quanto a fenomenologia clinica di un processo psicotico, descritta da una persona molto colta e intellettualmente molto acuta. In secondo luogo, lungi dall’essere un’opera d’arte, le Memorie intendono porsi come un’autodifesa – Schreber era giudice della camera di Appello di Dresda- durante un processo di incapacità (definita “insania” in alcuni Paesi) voluto da sua moglie Sabina. Vale a dire, era in gioco la capacità di poter disporre liberamente del suo denaro e dei suoi beni. In terzo luogo Schreber manifestamente dichiara che il suo lavoro «per la scienza e per la conoscenza di verità religiose potrebbe essere una cosa preziosa» cit. in Freud, p.340). Questo è quanto lo porta alla decisione di pubblicarlo. Tuttavia ci sono molti altri modi di leggere le Memorie. Nel mio caso mi sono avvicinato ad esse da una prospettiva psicopatologica. Leggendole è impossibile non notare che potrebbero essere considerate anche come un trattato di esoterismo, se per esempio ci riferiamo alla teoria della metempsicosi o della trasmigrazione dell’anima, oppure alla buona sorte o all’ordine cosmico. Si menzionano anche Ariman e Ormuz, antiche divinità che rappresentano il bene e il male nello zoorastrismo. Esplorando quello che Schreber chiama l’almicidio o assassinio dell’anima, atto perpetrato dalla famiglia di Flechsing, suo psichiatra, contro la famiglia di Schreber nel corso dei secoli, nel riferirsi a questo fenomeno egli non ha dubbi nell’affermare che l’idea di impossessarsi dell’anima di un’altra persona può procurare una vita più lunga, «è ampiamente diffusa nelle leggende e nelle poesie di tutti i popoli» -e questo è certo. Cita ad esempio il Faust di Goethe o il Manfred di Lord Byron o Il cacciatore furtivo di Weber, in cui assume un ruolo importante il Diavolo. Ed è a questo punto che conviene addentrarci nella storia clinica di Freud. Infatti, una delle cose che Schreber stabilisce sin dall’inizio è che Flechsing, il suo medico, è il principale artefice dell’omicidio dell’anima e degli altri tipi di abuso specialmente attraverso «una connessione nervosa chi gli era stata concessa al fine di avere ispirazioni divine, o anche per altri motivi, come ad esempio per trattenere i raggi divini» vale a dire per poter trattenere la sua anima. La centralità e la ripetizione di questo tema condurranno Freud, come vedremo più avanti, a concentrare la sua lettura nella relazione di transfert tra Schreber e Flechsing. Come affermava Heidegger «ogni descrizione è un’interpretazione».
Lettura della storia clinica di Freud: Il caso Schreber
Nel primo capitolo del lavoro Freud descrive tre episodi clinici, equivalenti a tre momenti critici nello sviluppo del processo psicotico di Schreber, e si occupa di chiarire soprattutto il secondo. Freud colloca il primo episodio nell’autunno del 1884, quando Schreber aveva 42 anni. In questa occasione Schreber fu ricoverato per sei mesi nella clinica del dr. Flechsing, che diagnosticò un «grave attacco di ipocondria» (Freud, 1910, p.342).
Dopo essersi ripreso da questa prima crisi, Schreber afferma di esser riuscito a convivere con sua moglie per otto anni, anni «nell’insieme assai felici, ricchi anche di onorificenze e turbati talora solo dalla ripetuta delusione della nostra speranza di avere bambini» (Freud, p.342-343).
Freud si sofferma soprattutto nei suoi successi precedenti alla apparizione della seconda crisi (e ne descrive succintamente una terza), riferendosi soprattutto alla nomina a presidente del Tribunale Superiore. Nel giugno 1893 viene infatti notificata la sua imminente nomina e Schreber «assunse la nuova carica il 1° ottobre dello stesso anno. Fra giugno e ottobre ebbero luogo alcuni sogni ai quali egli fu indotto solo più tardi ad attribuire importanza. Gli capitò cioè di sognare più di una volta che era tornata la sua passata malattia nervosa, cosa che in sogno lo riempiva di dolore tanto quanto si sentiva felice al risveglio, rendendosi conto che appunto non era stato che un sogno. Inoltre, una volta nelle prime ore del mattino, in uno stato tra il sonno e la veglia, gli si affacciò ‘la rappresentazione che dovesse essere davvero bello essere una donna che soggiace alla copula’, idea che in stato di piena coscienza egli avrebbe respinto con la più grande indignazione» (Freud, p.343).
È essenziale evidenziare questo periodo della psicosi di Schreber per chiarire la genesi del suo delirio. È tra giugno e ottobre 1893, tra la sua nomina all’incarico e la sua assunzione, che possiamo individuare il periodo di incubazionedella sua psicosi, l’attimo prima dell’inizio del delirio. Questo intervallo, che Freud segnala come precedente al superlavoro – il surmenage – al quale Schreber attribuirà più tardi la colpa della sua seconda malattia, gli permette di individuare quello che sarà il germe principale dell’intero delirio: la questione della trasformazione in donna (Verweiblichung) – dover essere una donna-.
Continuiamo con Freud:
La seconda malattia si manifestò alla fine d’ottobre del 1893 con una insonnia tormentosa che lo indusse a rientrare nella clinica del dottor Flechsing, dove tuttavia il suo stato peggiorò rapidamente. Lo sviluppo ulteriore del male è descritto in una perizia rilasciata successivamente [nel 1899] dal direttore della casa di cura Sonnenstein: ‘All’inizio di tale soggiorno egli espresse più volte idee ipocondriache, si lamentava di soffrire di rammollimento cerebrale, di dover presto morire ecc., ma nel quadro clinico cominciarono già ad affiorare idee di persecuzione […] mentre nello stesso tempo cominciava a manifestarsi una notevole iperestesia e grande sensibilità a luce e rumore. In seguito le allucinazioni visive e acustiche divennero più frequenti e, insieme a disturbi sensori comuni, finirono per dominare la totalità delle sue sensazioni e riflessioni; egli riteneva di esser morto e in parte già putrefatto, malato di peste, vaneggiava che il suo corpo fosse oggetto di orribili manipolazioni di ogni genere […]. Le suggestioni morbose assorbivano a tal punto il malato che egli se ne stava per ore e ore del tutto immobile (stupor allucinatorio), inaccessibile a qualunque altra impressione, e d’altra parte lo tormentavano a tal punto che invocava la morte, sicché egli cercò ripetutamente di annegarsi nel bagno ed esigeva il ‘cianuro destinatogli’. Le idee deliranti assunsero gradualmente un carattere mistico e religioso; egli comunicava direttamente con Dio […] e giunse addirittura a credere di vivere in un altro mondo’ (Freud, pp.343-344).
Ricordiamo che Schreber insultò diverse persone dalle quali si sentiva perseguitato e offeso, soprattutto il suo ex medico Flechsig: «che chiamava ‘assassino di anime’» (Seelenmörder ) (p.344).
Per Freud il delirio di Schreber si può dividere in due fasi, mediate da una svolta, raccontata da Schreber nel capitolo XIII delle Memorie:
- Fase 1: Delirio di persecuzione sessuale. Complotto. Flechsig appare come il persecutore centrale. Lo “scopo” di tale persecuzione è l’abuso sessuale, e poi «lasciamolo lì, disteso per terra».
- Punto di Svolta: collocato nel Capitolo XIII delle Memorie; nello specifico, Schreber si riferisce al mese di novembre 1895, periodo in cui «si stabilì il legame tra la fantasia di evirazione e il delirio di redenzione, e in questo modo fu facilitata una riconciliazione con la prima».
- Fase 2: Delirio religioso di grandezza, mistico o di redenzione. Lo “scopo” in questa fase di delirio non è più l’«abuso sessuale», ma la procreazione di una nuova razza di uomini schreberiani essendo lui lamoglie di Dio, risolvendosi così il conflitto e ciò consentendo una certa stabilizzazione clinica.
Ci sono diverse parole e frasi che si ripetono molto frequentemente nel testo di Schreber, e proprio questa insistenza testuale è ciò che porta Freud a attribuire loro un’importanza fondamentale. L’almicidio di cui sopra, i raggi di Dio, la trasformazione in donna, la beatitudine, le anime sottomesse [al giudizio di Dio], la lingua fondamentale, i nervi e la voluttà sono gli esempi più rilevanti. Ma secondo Freud, «nessun’altra parte del delirio è illustrata dal malato con tanta ricchezza di particolari e si potrebbe dire, con tanta insistenza, come la sua pretesa trasformazione in donna» (p.360)
Metodologia e costruzione del caso Schreber
A seguire, cerchiamo di individuare e svelare le premesse metodologiche fondamentali che strutturano tacitamente il resoconto clinico di Freud, per poi analizzarle a partire dall’ermeneutica testuale di Ricœur.
Le sei premesse metodologiche
La prima premessa metodologica, e forse la più importante, è quella che stabilisce che «è possibile supplire alla conoscenza personale del malato con una relazione scritta o con un caso clinico stampato» (Freud,1910, p.339), in ragione dell’affermazione che non è possibile forzare le resistenze interne del paranoico.
La seconda premessa metodologica ci viene presentata suddivisa in due elementi che meritano di essere distinti, laddove il primo si presenta come un assioma, cioè un postulato generale e universale riguardante lo studio della soggettività psicotica. Esso implica l’affermazione che anche i deliri paranoici, per quanto stravaganti possano essere, hanno origine da impulsi pulsionali che sono, secondo Freud, universali: «lo psicoanalista assume […] la congettura che anche tali formazioni di pensiero stravaganti, così lontane dalla realtà i dai pensieri ordinari degli uomini –cioè le formazioni deliranti – abbiano origine nei moti più universali e comprensibili della vita psichica».
Il secondo elemento – che rappresenta più specificamente la premessa metodologica propriamente detta – rimanda al desiderio di sapere come e per quali «motivi» queste pulsioni si siano «trasformate» in quella specifica modalità di presentazione, cioè nella formazione delirante. «A tal fine -continua Freud- [l’analista] approfondirà volentieri la storia dello sviluppo così come i dettagli del delirio». L’approfondimento della storia dello sviluppo mira allo studio meticoloso delle vicende biografiche di Schreber e si riferisce a tutti gli elementi del materiale clinico che appaiono legati ad alcuni dettagli del delirio.
La terza premessa metodologica riprende proprio la questione di «ciò che si ripete», ma con riferimento al testo. Ricordiamo poi che ci sono alcune parole chiave nel testo di Schreber: almicidio, raggi di Dio, trasformazione in donna, beatitudine, anime sottomesse al giudizio, lingua fondamentale, nervi e voluttà. Tra tutti, Freud mette in risalto soprattutto la trasformazione in donna, poiché è l’elemento più sorprendente e insistente nella scrittura. In effetti, questo elemento funziona per Freud come la pietra angolare dell’intero processo della sua interpretazione.
La quarta premessa metodologica, posta quasi come un’ouverture al secondo capitolo della storia, distingue due vertici di approccio al testo schreberiano: il primo, mira a interpretare direttamente le «frasi deliranti» così come appaiono nel testo, mentre il secondo si propone di studiare dati di realtà, localizzati nella realtà materiale oggettiva, che operano come fattori scatenanti le crisi. Questa strategia è ciò che ci permette di localizzare «i complessi ben noti e le forze istintive della vita mentale». Non troviamo qui nuovamente operanti i due concetti di realtà – Wirklichkeit (realtà materiale) e Realität (realtà psichica) –?
Ma Freud sostiene anche che Schreber «mette le chiavi nelle nostre mani», aggiungendo a una frase delirante, una delucidazione, una citazione o un esempio, o negando una somiglianza che gli viene in mente. Alcune frasi del testo permettono a Freud di operare una decifrazione, lasciandosi guidare dalle spiegazioni, citazioni ed esempi che lo stesso Schreber fornisce.
In alcune occasioni, Freud sembra anche fare appello al modo di operare della ‘negazione’ come un’altra risorsa valida per decifrare il testo, soprattutto quando si riferisce a quelle occasioni in cui Schreber viene a porre «obiezioni manifestamente espresse» dinanzi ad alcune somiglianze associative che in lui stesso sorgono spontaneamente. Questa sequenza operativa si conclude quindi provvisoriamente con la traduzione (Übersetzung) ricercata.
Ma che razza di “traduzione” è? È a questo punto che Freud non fa altro che ripercorrere, a ritroso, le modalità di alterazione dello stile espressivo paranoico per poterle ricondurre ai complessi già noti individuati in altre nevrosi, ad esempio il complesso paterno. D’altro canto, questo metodo gli permette a sua volta di rivelare le forze istintuali in gioco dietro il discorso paranoico.
La quinta premessa metodologica postula che «è lecito considerare la paranoia alla luce del modello del sogno». Se ricordiamo qui che il nucleo della formazione delirante di Schreber è il suo rapporto con il suo primo medico, cioè con P. Flechsig, dobbiamo sottolineare che la nozione stessa di lavoro di formazione delirante (Wahnbildungsarbeit) è un’allusione diretta al suddetto modello onirico al fine di rendere intelligibile il delirio, cioè renderlo metodologicamente accessibile al processo interpretativo.
Occorre quindi concepire insieme questi due postulati: è lecito concepire la paranoia alla luce del modello del sogno e del «lavoro di formazione delirante» (Wahnbildungsarbeit). La parola tedesca Wahnbildungsarbeit, che significa ‘lavoro di formazione delirante’, è concettualmente vicina a Traumarbeit, ‘lavoro del sogno’. Wahnbildungsarbeit (letteralmente Wahn: delirio; Bildung: creazione, fondazione, formazione; Arbeit: lavoro, fatica, occupazione, sforzo): sottolineiamo che qui Arbeit indica il lavoro soggettivo. Si tratta del coinvolgimento soggettivo dello psicotico nella produzione delle sue formazioni deliranti.
Infine, la sesta premessa metodologica propone una lettura all’incrocio tra la biografia di Schreber e il suo delirio: «Sappiamo già che quando si produce una fantasia di desiderio è nostro compito metterla in relazione con una frustrazione, una privazione imposta dalla vita reale», afferma Freud (1910, p.383).
Nella citazione da cui abbiamo derivato questa sesta premessa vediamo operare, in modo articolato e congiunto, l’idea che la paranoia rappresenti alcuni conflitti in modo similare al testo onirico – motivo per cui il materiale potrebbe essere ‘alterato’ – e, d’altra parte, una precisazione sul compito interpretativo centrale relativamente a come operare questa intersezione tra biografia e delirio: quando parla di biografia, Freud ci dice di dirigere la nostra attenzione verso le privazioni, le negazioni o le frustrazioni libidiche del soggetto per poterne costruire, connettere, localizzare il contesto e le relazioni di interdipendenza (la parola tedesca Zusammenhang racchiude tutti questi significati) non più con il ‘delirio’ e basta, ma con il delirio letto – interpretato – come Wunschphantasie, come fantasia di desiderio, come compensazione delle frustrazioni della libido che hanno operato in modo traumatico per il soggetto. Si tratta, quindi, di individuare le connessioni (die Zusammenhängen) tra una privazione (Versagung) e una fantasia di desiderio (Wunschphantasie).
Seguendo l’analisi di Ricœur, il quale stabilisce l’epistemologia freudiana come un discorso misto, che si occupa sia di forze che di significati, collochiamo ora queste idee nella storia di Schreber, effettivamente concepita e presentata a questi due livelli di analisi: 1) il modello energetico, legato alla teoria libidica della rimozione e 2) il modello semantico-testuale, grazia al quale Freud traduce in frasi – o viceversa – i diversi movimenti della libido intesa in termini economici. In questo preciso senso Ricoeur afferma che «la psicoanalisi non si trova mai di fronte a forze nude, ma sempre a forze in cerca di senso; Questa connessione della forza con il significato è ciò che fa della pulsione stessa […] un concetto-limite al confine tra organico e psichico».
Il modello ‘testo’ come marker epistemico-metodologico dell’interpretazione freudiana delle Memorie di Schreber
Le Memorie come ‘testo’
Ritorneremo alle premesse metodologiche delineate dalla lettura della storia clinica freudiana per reinterpretarle ora a partire dalla categoria di ‘testo’ tratta dall’ermeneutica testuale di Ricœur. Il concetto di «mondo del testo» di Ricœur (inteso come l’insieme dei riferimenti aperti dai testi) funziona come un ‘ponte’ tra la filosofia del linguaggio di Ricœur (a partire da un piano strettamente metodologico) e il processo di interpretazione delle Memorie di Schreberrealizzato da Freud.
Dalla libera associazione alla prima modalità di lettura
Cominciamo considerando la prima premessa metodologica sollevata da Freud nella storia clinica, poiché è proprio quella che funziona come transizione, come punto di passaggio tra discorso parlato e discorso scritto, ma che tuttavia manca di un concetto meglio delimitato di ‘testo’. Tale premessa stabilisce che «Poiché i paranoici non possono essere indotti forzatamente a superare le loro resistenze interne e comunque dicono solo quel che hanno voglia di dire, proprio per questa malattia è possibile supplire alla conoscenza personale del malato con una relazione scritta o con un caso clinico stampato» (Freud, 1910, p.339). Se sostituiamo l’incontro personale con l’interpretazione del resoconto scritto, il ‘testo’ è ciò che qui sostituisce il metodo psicoanalitico basato sul faccia a faccia.
Ma la cosa più evidente, da cui Freud trae appoggio per introdurre poi le sue interpretazioni, è quanto formulato dalla terza premessa metodologica, che riprende proprio l’insistenza e la ripetizione nel testo di certe espressioni. Potremmo così proporre che questa sia la prima modalità di lettura compiuta da Freud: raccogliere la ripetizione.
Infine sembra esserci una sorta di traduzione implicita che va dall’idea del testo del sogno all’esame del testo del delirio; tuttavia lì era necessario completare questo trasferimento o analogia metodologica inserendola nell’universo del ‘testo’ inteso in senso ricœuriano, poiché il ‘testo’ a cui Freud fa riferimento, ad esempio nell’Interpretazione dei sogni, era un testo parlato, un testo non definito in quanto tale ma piuttosto utilizzato come una analogia concettuale e metaforica vicina alla scrittura, in particolare a quella geroglifica.
La ‘frase’ come prima unità di analisi nel quadro del ‘testo’
Torniamo qui alla quarta premessa metodologica, poiché essa stabilisce chiaramente la prima unità di analisi esplicitata da Freud. Ci riferiamo alla distinzione tra due vertici di approccio al testo schreberiano: il primo, ricordiamo, mirato a interpretare direttamente le ‘frasi deliranti’ così come appaiono nel testo e il secondo mirato a studiare gli eventi, individuabili nella realtà materiale oggettiva, che hanno funzionato come fattori scatenanti della crisi.
Questa strategia è ciò che ha portato Freud a individuare «i complessi e le forze motrici ben noti della vita mentale», concepiti come universali, quali ad esempio il complesso paterno.
Scopriamo qui che l’unità di analisi utilizzata da Freud non è semplicemente la ‘parola’ come elemento indipendente e autosufficiente. L’unità esplicita di analisi è la ‘frase’, la frase delirante (wahnhaften Satz); ma d’altra parte, Freud suggerisce di prendere in considerazione le frasi deliranti che si riferiscono, in relazione alla biografia, ai dati della vita reale, materiale e oggettiva di Schreber, al fine di ricostruire i contesti che scatenano le crisi. Ed è anche una ‘frase’ quella cui Freud giunge per stabilire la formula semantico-grammaticale della rimozione nella paranoia: «Io (un uomo) amo lui (un uomo)» (Freud, 1910, p.389), legata all’avanzare della libido omosessuale.
La metodologia proposta – l’ermeneutica testuale – è coerente con il tipo di unità di analisi stabilita da Freud: ci riferiamo specificamente alla distinzione che Ricœur opera tra i due livelli del linguaggio, quello semiotico (strutturalista) e quello semantico (ermeneutico). Detto livello semantico pone la frase o l’enunciato come l’unità minima significativa, cioè plausibile per produrre significato.
Inoltre, Freud rivolge la sua attenzione ai collegamenti (come nella scrittura geroglifica egiziana), alla ‘rete di connessioni’ (Zusammenhang), alle molteplici interrelazioni tra delirio ed eventi biografici, essendo questo un orizzonte interpretativo fondamentale della cronaca di vita schreberiana.
Ma per arrivare a questo Freud ha dovuto prima selezionare le frasi e le parole decisive; Vorremmo dimostrare che, come afferma Ricœur, non esiste momento ermeneutico senza passare per il momento strutturalista. Per momento strutturalista si intende la selezione di parole e frasi che insistono e si ripetono nel testo; ma è anche nostra intenzione mostrare che questa è solo la prima parte del processo, che mancherebbe di senso e di significato se non venisse poi articolato con il momento ermeneutico, in cui si passa dalla logica del segno alla logica della frase o del discorso, in questo caso del discorso scritto.
Nel momento strutturalista del processo interpretativo, non si tratta ancora dei contenuti, della semantica, del significato metaforico o letterale delle frasi, ma di individuare e isolare gli elementi più ripetuti, senza nemmeno considerare il contenuto e il suo significato, ma prendendo in considerazione gli aspetti formali del discorso scritto.
Sono insomma al centro dell’attenzione l’insistenza e la ripetizione testuale nelle Memorie, intese come una totalità, come un’opera, come un discorso strutturato, fissato dalla scrittura, che mantiene stabile il suo significato. E lo stesso accade con le frasi più importanti: ‘raggi di Dio’, ‘trasformazione in donna’, ‘anime sottoposte a giudizio’ e ‘lingua fondamentale’, essendo la trasformazione in donna la spina dorsale, che Freud rinviene in tutto lo sviluppo della psicosi di Schreber, dall’esordio alla fase terminale.
Ora, consideriamo che la lettura delle Memorie da parte di Freud è conforme a questo procedimento, poiché Freud non intende ripristinare una presunta intenzionalità dietro il testo né fare una descrizione della psicologia di Schreber, ma piuttosto, attraverso il processo di interpretazione, estrarre dalle Memorie l’essenziale delle modalità di difesa inconsce della soggettività psicotica, analizzando il testo, mostrando il suo mondo immanente per leggerlo psicoanaliticamente.
Il ‘mondo’ delle Memorie a partire dalla storia clinica di Freud
Esploreremo ora questo punto, facendo riferimento all’esame della sesta premessa metodologica, che ci propone un intreccio tra la biografia di Schreber e il suo delirio: «sappiamo che il nostro compito è intrecciare l’emergere di una fantasia di desiderio con una frustrazione […], una deprivazione della vita reale e oggettiva», afferma Freud.
Ma quando si fa riferimento alla ‘biografia’ – come abbiamo visto -, Freud ci invita a rivolgere l’attenzione verso le privazioni, le negazioni o le frustrazioni libidiche del soggetto per stabilire relazioni (Zusammenhang) non solo con il ‘delirio’ sic et simpliciter, ma con il delirio interpretato come Wunschphantasie, come fantasia del desiderio. Ciò che Freud individua con le sue interpretazioni sono le connessioni tra privazioni (Versagungen) e fantasie di desiderio (Wunschphantasien).
Dal punto di vista metodologico, Freud elabora le sue congetture aderendo al testo, ma effettua la sua operazione di lettura a partire dalla sospensione dei riferimenti del discorso descrittivo, così come la propone Ricœur in relazione all’ ‘opera poetica’, che noi possiamo ora chiamare semplicemente ‘opera’ (con riferimento alla totalità del testo nel suo insieme), dato che sarebbe impossibile analizzare il testo-delirio di Schreber affrontandolo come un discorso descrittivo il cui referente sia solo la realtà materiale oggettiva. Il processo freudiano di interpretazione culmina infatti nell’elaborazione di una serie di riferimenti non descrittivi: è il caso del Versagung, la deprivazione e negazione della soddisfazione libidica e, in definitiva, dei movimenti, delle fissazioni e delle stagnazioni della libido in generale.
Ricœur postula che si tratti di «dispiegare il testo non più verso il suo autore, ma verso il suo senso immanente». Affermiamo anche che il ‘mondo del testo’, il ‘mondo del delirio’ di Schreber, rigenera il mondo crollato dalla crisi, operando una ridescrizione o riconfigurazione, e producendo anche un’innovazione semantica. Ancora una volta Freud non si ferma a ‘ciò che Schreber intendeva dire’, ma alla logica della sua psicosi, decifrata grazie a questa operazione di lettura unica e inedita.
Bibliografia:
Freud S. (1910), Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia descritto autobiograficamente, in Opere, vol.6, Boringhieri, Torino 1974
Iglesias Colillas I. (2022), Psicosis y escritura, Xoroi Edicions, Barcelona.
Schreber D.P.(1902), Memorie di un malato di nervi, Adelphi, Milano, 1974
Trascrizione, rivista dall’autore, della relazione tenuta il 18 maggio nell’ambito del ciclo di seminari LAPEF “Pulsione creativa e piacere estetico”. Traduzione di Giuseppe Martini